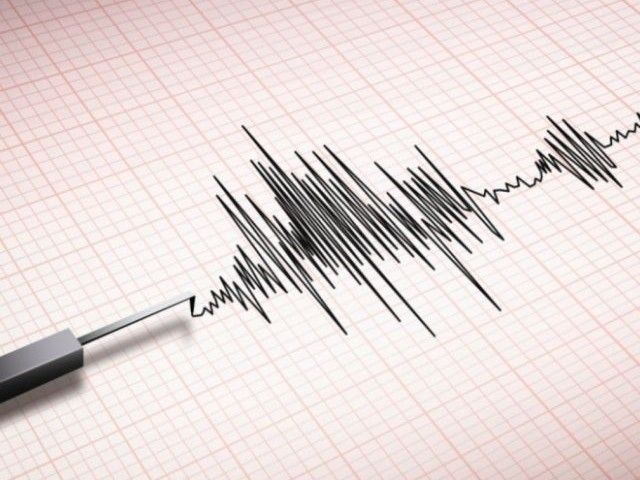La Piana Abissale a Ferro di Cavallo, una formazione geologica nell'Oceano Atlantico non lontana dalla montagna sottomarina Gorringe Bank, al confine tra la placca tettonica eurasiatica e quella africana, è l'origine geografica del terremoto di quasi 8 gradi della scala Richter che nel 1969 ha scosso Lisbona e altre regioni del Paese.
Il fatto che si tratti di una formazione geologica pianeggiante, senza faglie sismiche importanti conosciute, ha alimentato un "rompicapo" nella comunità scientifica su come una regione con queste caratteristiche possa aver causato terremoti di tale entità. Tuttavia, uno studio della Facoltà di Scienze dell'Università di Lisbona, pubblicato oggi sulla rivista Nature Geosciences, offre una nuova possibile spiegazione.
In quell'area, "non era mai stata trovata alcuna faglia evidente" che potesse spiegare un terremoto della magnitudo di quello del 1969, ha dichiarato João Duarte, uno dei co-autori dello studio, geologo, professore presso la Facoltà di Scienze dell'Università di Lisbona e ricercatore presso l'Istituto Dom Luiz.
Ad accrescere l'enigma e a motivare la ricerca è il fatto che "non è mai stata trovata una faglia di dimensioni sufficienti a generare un terremoto come quello del 1755", che si ritiene abbia avuto un'intensità prossima al 9 della scala Richter.
Secondo João Duarte, ciò che è stato ora rivelato e che potrebbe spiegare l'origine di entrambi i terremoti è che "una parte della placca tettonica si sta separando", in un processo chiamato delaminazione.
Questa delaminazione implica che la placca sta subendo una frattura orizzontale, come se la roccia fosse separata da una lastra, aprendo una fessura che fa sprofondare la parte inferiore, che ha già raggiunto una profondità di 200 chilometri verso il mantello terrestre, quando la profondità normale è di circa 100 chilometri.
La parte superiore della placca rimane in una posizione orizzontale inalterata, rendendo impossibile rilevare qualsiasi cambiamento geologico in quel luogo osservando il fondale marino, ha spiegato il ricercatore a Lusa.
Questo processo di separazione orizzontale delle placche, che si è verificato lentamente per cinque-dieci milioni di anni, è stato identificato utilizzando una sorta di "ecografia terrestre", ha spiegato il professore, riferendosi all'uso della tomografia sismica e del suono catturato - il suono dei terremoti stessi - per capire cosa sta accadendo sotto il fondale marino.
"Abbiamo condotto uno studio che ha posizionato dei sismometri sul fondo del mare per otto mesi, registrando piccoli terremoti. Abbiamo notato che in quell'area c'era un 'cluster', un insieme di piccoli terremoti a grande profondità, circa 30-40 chilometri di profondità, il che è alquanto anomalo. Pertanto, la combinazione di diverse osservazioni indica che in quell'area si sta verificando un processo che genera sismicità", ha spiegato il ricercatore.
"Sappiamo che anche la placca africana si sta muovendo molto lentamente, convergendo con la placca eurasiatica. È come se immaginassimo di avere due libri e uno iniziasse a scivolare nell'altro. Le placche stanno convergendo e, in realtà, la zona in cui la placca inizia a separarsi si comporta un po' come una foglia, perché inizia a scivolare nell'altra placca. Il contatto c'è sempre, ma è un contatto più orizzontale. In altre parole, non c'è più un buco, non c'è più spazio. Quello spazio viene poi occupato da altre rocce", ha spiegato João Duarte.
Indagini future
João Duarte spera che questo studio porti a future indagini più dettagliate su quell'area. Con quello che già sappiamo, dice che è inevitabile che questo processo di delaminazione venga preso in considerazione "nella caratterizzazione della pericolosità e del rischio sismico" nel Paese, già considerato un'area ad alto rischio a causa della confluenza di due placche tettoniche in questa regione.
Il ricercatore vede un'opportunità nell'installazione di una nuova generazione di cavi sottomarini - cavi di comunicazione che collegano entrambe le sponde dell'Atlantico, passando attraverso gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madeira e anche attraverso la pianura abissale del Ferro di Cavallo.
"Avranno sensori sismici, quindi i cavi attraverseranno quell'area, consentendo di monitorare e caratterizzare meglio la sismicità. E probabilmente avremo anche più dati, più registrazioni", ha detto.
La visibilità dei terremoti rimane un sogno irrealizzabile, ma João Duarte ritiene che l'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare un passo avanti, anche se un modello di apprendimento basato su eventi e dati precedenti presenta delle sfide in questo caso, perché i grandi terremoti sono fenomeni rari.
La chiave potrebbe risiedere in uno studio più sistematico dei terremoti più piccoli, che si verificano ogni giorno, anche in Portogallo, "con la speranza" di comprendere il processo di sismicità e "fare alcune inferenze e usare le statistiche per capire i terremoti più grandi".